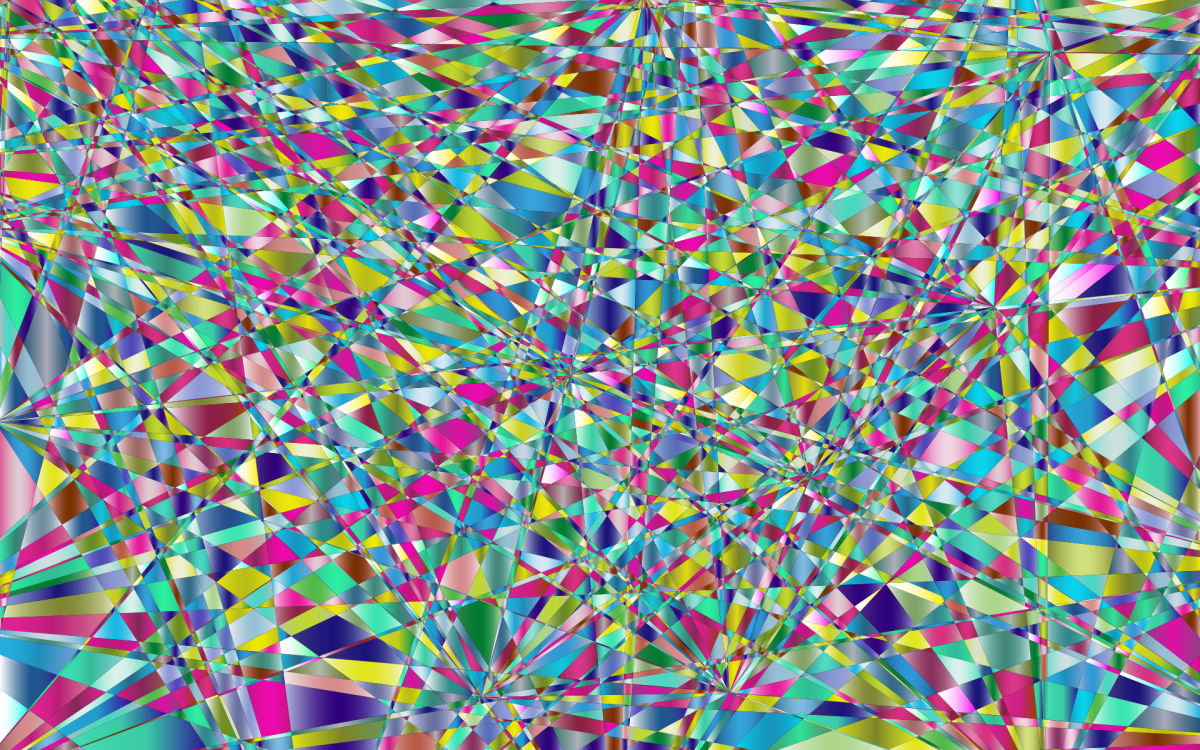Alcune note su Mark Rothko di Furio Durando
(2010 – Conferenza tenuta presso il Cantinone Arte Teatri, Montepulciano)
Mi piace iniziare questa breve presentazione di Mark Rothko (1903-1970) con le parole che gli dedicò, nel 1958, Gillo Dorfles: “La pittura di Rothko costituisce a un tempo un limite (come fu a suo tempo per quella di Mondrian), ma anche un inizio: l’inizio d’un nuovo tonalismo. Dopo cinquant’anni di pittura quasi esclusivamente sul colore-materia, sul colore-pigmento, ecco risorgere in tutt’altra guisa e con tutt’altra implicazione, la pittura tonale; ma non già quella paesaggistica o ambientale, quella basata sul plein air impressionista e che ebbe il suo canto del cigno nelle Nymphées di Monet, ma una pittura tonale il cui compito non è di rispecchiare o copiare un’atmosfera, ma di inventarla, di crearla ex novo. Rothko crea, con le sue immense, vaste, solitarie tele (dove soltanto una o due tinte, soltanto qualche lieve banda sta a segmentare lo spazio) un universo atmosferico in cui bagnano le cose, le persone, la stessa circostante e antistante natura. (...)... un canto senza parole...”.
Il Novecento è stato il secolo in cui è stato spesso più facile, e soprattutto più necessario, dire “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” – per usare versi di Eugenio Montale; e per questo l’artista – quartogenito di una giovane coppia di ebrei lettoni (il cognome originario era Rothkowitz), nato a Dvinsk (Lettonia) nel 1903 ed emigrato decenne a Portland (Oregon) con la famiglia – ripeté più volte di non essere e di non voler essere considerato un astrattista, a dispetto della prima impressione che le sue tele, ricoperte da sequenze cromatiche d’esatta proporzionalità e di impalpabile definitezza nei passaggi di tono, possono destare nello spettatore superficialmente predisposto (più che preparato). Egli cercò di esprimere nelle sue tele “le emozioni fondamentali dell’uomo, la tragedia, l’estasi, la sorte” – sono parole sue – e dunque rigettò totalmente come formalismi insignificanti i linguaggi del Bauhaus e di De Stijl (Mondrian incluso). La sua poetica cercava di intridersi di vita vera, di concretezza, di indivisibilità: più dell’aleatoria idea di convergenza del classico nel moderno per il tramite di un forte rapporto istituito tra forma e contenuto, gli interessò ripartire dall’idea rinascimentale
dell’uomo vitruviano e leonardesco, della forma non già adibita a posteriori al contenuto, ma consustanziale ab origine ad esso, e dunque per questo variabilmente modulabile: non poteva che sortirne una nuovissima lettura del classico in termini romantici, una vivificazione ed una

restituzione alla dualità nell’unità di spirito e materia di ciò che nei suoi equilibri compiuti è perfezione ammirevole, ma destinata a sterili solitudini.
E che questo giunga per mano di ciò che è – in quanto spirito tumultuante di passione – destinato a sterili commerci, senza l’incanto dell’armonia raggiunta, spiega molto delle elementari ed insinuanti simmetrie, proporzioni, dialettiche intense di sentimenti e tuttavia intessute d’una serenità costante, che troviamo nelle sue tele.
Finestre di colore, esili frameworks smarginati non per incertezza dei limiti, ma per osmosi delle luci e dei colori di anime distinte e non diverse, sulle quali dobbiamo solo affacciarci per ritrovare chi siamo al di là di ogni maschera.
Omaggio a Matisse (1954) non è un’evocazione della joie de vivre dell’artista francese, né un espressionistico tributo a 70 anni di cromismo psichico: è un gioco di rettangoli aurei ed altre forme in diafania cromatica, fra toni che saturano, se la finestra s’affaccia sullo spirito, o che lasciano intravedere l’incompletezza e l’insostenibilità di una visione fondata sull’asseverazione passiva del contingente come condizione fatale dell’uomo.
La ricerca di rapporti aurei fra spazi-colore che si compenetrano è evidente in N° 203 (Rosso, Arancio, Tannino e Porpora), del  1954, nel quale il numero φ esprime la proporzione fra i due campi maggiori; e parimenti in Senza titolo del 1956, una finestra oltre la quale un frammento regolare dell’universo, giallo oro, effetto di luce assorbente, lascia intuire un’infinito/indefinito. Apollo, la ragione, la misura concedono e rivelano all’uomo la prospettiva dell’infinito, ma in tanta luce la vista non scorge, la ragione non penetra, Apollo – ghignante come nella statua fittile etrusca rinvenuta a Veio e attribuita a Vulca – ribadisce per l’uomo la necessità di un consapevole naufragio. E che il tutto abbia la proporzione ideale è consolazione e condanna, gioia di vivere e nostalgia.
1954, nel quale il numero φ esprime la proporzione fra i due campi maggiori; e parimenti in Senza titolo del 1956, una finestra oltre la quale un frammento regolare dell’universo, giallo oro, effetto di luce assorbente, lascia intuire un’infinito/indefinito. Apollo, la ragione, la misura concedono e rivelano all’uomo la prospettiva dell’infinito, ma in tanta luce la vista non scorge, la ragione non penetra, Apollo – ghignante come nella statua fittile etrusca rinvenuta a Veio e attribuita a Vulca – ribadisce per l’uomo la necessità di un consapevole naufragio. E che il tutto abbia la proporzione ideale è consolazione e condanna, gioia di vivere e nostalgia.
 Per tale motivo è doveroso prendere in considerazione gli ultimi dipinti dell’artista statunitense, quei Black-on-gray paintings che costituiscono il suo lucido e disperato addio alla vita (morì suicida, tagliandosi le vene delle braccia con un coltello da cucina, dopo aver constatato l’irreversibile crisi e rottura del proprio matrimonio), ma anche una sontuosa riaffermazione dei principi informatori di un’arte vissuta con pienezza.
Per tale motivo è doveroso prendere in considerazione gli ultimi dipinti dell’artista statunitense, quei Black-on-gray paintings che costituiscono il suo lucido e disperato addio alla vita (morì suicida, tagliandosi le vene delle braccia con un coltello da cucina, dopo aver constatato l’irreversibile crisi e rottura del proprio matrimonio), ma anche una sontuosa riaffermazione dei principi informatori di un’arte vissuta con pienezza.
 Si esamina qui un acrilico su tela di grandi dimensioni (203 per 175 cm circa), Senza titolo (Nero su grigio): alle proporzioni auree degli anni ’50 e dei primi anni ’60 si è sostituita una netta partizione a metà della tela. Un desolante grigio ingombra la metà inferiore, sovrastato e quasi schiacciato dal nero di una notte senza luna né stelle. Solo con un’attenta analisi ci si accorge che Rothko ha applicato, nella stesura di questo grigio (chiaro) inferiore, che presuppone un’idea di profondità perché vi possa sensatamente incombere il nero notturno, un’impercettibile correzione ottica di memoria partenonica – o forse semplicemente “aurea”. Se osserviamo la linea di confine, interagiscono lungo di essa un’appena percettibile sfumatura di tono più chiaro, e una regolare, perfettamente assializzata, ma lievissima convessità del grigio, misurabile con un calibro.
Si esamina qui un acrilico su tela di grandi dimensioni (203 per 175 cm circa), Senza titolo (Nero su grigio): alle proporzioni auree degli anni ’50 e dei primi anni ’60 si è sostituita una netta partizione a metà della tela. Un desolante grigio ingombra la metà inferiore, sovrastato e quasi schiacciato dal nero di una notte senza luna né stelle. Solo con un’attenta analisi ci si accorge che Rothko ha applicato, nella stesura di questo grigio (chiaro) inferiore, che presuppone un’idea di profondità perché vi possa sensatamente incombere il nero notturno, un’impercettibile correzione ottica di memoria partenonica – o forse semplicemente “aurea”. Se osserviamo la linea di confine, interagiscono lungo di essa un’appena percettibile sfumatura di tono più chiaro, e una regolare, perfettamente assializzata, ma lievissima convessità del grigio, misurabile con un calibro.
Rothko è arrivato – per dirla con le parole di Borges – “al suo centro”, all’essenza di un percorso in fondo al quale il sogno dell’infinito si risolve in finitezza dell’illusione ed azzeramento, ma – fuor d’ogni neoromanticismo – il teatro dell’illusione rivelata è un’eliotiana terra desolata affacciata sul buio. A ben vedere, proprio la curva dell’orizzonte rivela all’osservatore che – con gli occhi di Rothko – quel deserto più stralunato che lunare appartiene non ad un pianeta sferico, ma ad un disco piatto e regolare, sospeso nel buio dell’universo. Camminando con l’artista verso il limite – la fine! – ed il margine di questo mondo totalmente inaridito e inospitale, riflesso di un denudamento interiore senza salvezza, se questo mondo è un disco non potremo che vedersi accorciare e progressivamente restringere, sfuggire ai margini del nostro campo visivo proprio la linea dell’orizzonte. Nella prospettiva che si limita e riduce è tutto il senso della fine. Dall’armonia perfetta della sfera e del cerchio, dall’equilibrio del centro, alla perdizione di un nulla eterno ed infinito, o semplicemente di un’oscurità indecifrabile. “All is the same, / time has gone by: / some day you came, / some day you’ll die. / Someone was hurt / long time ago, / someone who tried / but didn’t know.”, per dirla con gli ultimi versi scritti da un altro lucido suicida, Cesare Pavese, vent’anni prima di Mark Rothko.